Studiando tutte le informazioni che hanno riguardato e riguardano la pandemia da covid19, un gruppo di scienziati hanno rivelato che gli individui con diagnosi di diabete di tipo 2 erano più a rischio di incorrere in forme severe di covid19.
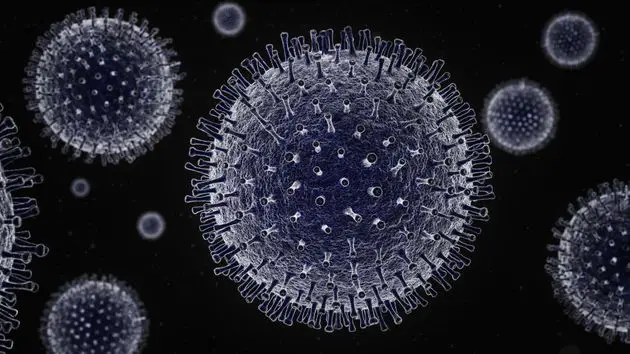
I risultati dello studio sono stati pubblicati su PNAS.
Diabete e covid19: cosa dice la ricerca?
Con molta probabilità, il responsabile di questa infelice correlazione è un enzima chiamato SETDB2. Questo stesso enzima è stato implicato nelle ferite infiammatorie non cicatrizzanti trovate nelle persone con diabete. Lavorando nel laboratorio di Katherine Gallagher, MD dei dipartimenti di chirurgia e microbiologia e immunologia del Michigan, il ricercatore W. James Melvin, MD, e i suoi colleghi hanno deciso di valutare un possibile legame tra l’enzima e l’infiammazione incontrollata a cui hanno assistito in prima persona nei pazienti COVID in terapia intensiva.
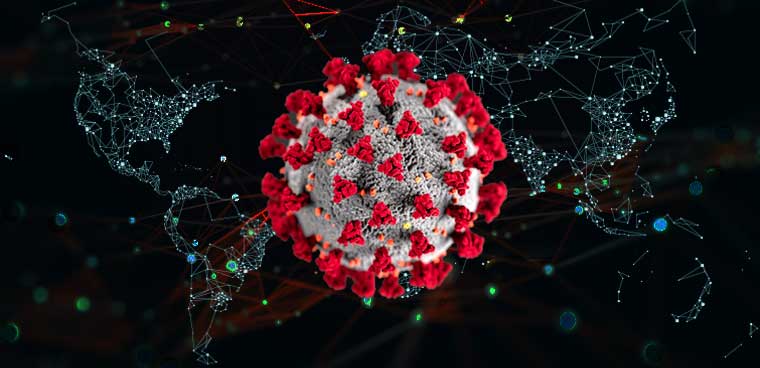
Partendo da un modello murino di infezione da coronavirus, hanno scoperto che SETDB2 era diminuito nelle cellule immunitarie coinvolte nella risposta infiammatoria, chiamate macrofagi, di topi infetti e con diabete. In seguito hanno osservato la stessa cosa nei monociti-macrofagi nel sangue di persone con diabete e grave COVID-19.
“Pensiamo di avere una ragione per cui questi pazienti stanno sviluppando una tempesta di citochine”, ha dichiarato Melvin.
Nei modelli murini e umani Melvin e Gallagher hanno osservato che quando SETDB2 è diminuito, l’infiammazione è aumentata. Inoltre, hanno rivelato che un percorso noto come JAK1/STAT3 regola SETDB2 nei macrofagi durante l’infezione da coronavirus.
Presi insieme, i risultati indicano un potenziale percorso terapeutico. Precedenti risultati del laboratorio hanno dimostrato che l’interferone, una citochina importante per l’immunità virale, aumenta il SETDB2 in risposta alla guarigione delle ferite. Nel loro nuovo studio, gli scienziati hanno scoperto che il siero sanguigno di pazienti in terapia intensiva con diabete e COVID-19 grave aveva livelli ridotti di interferone-beta rispetto ai pazienti senza diabete.
“L’interferone è stato studiato durante la pandemia come una potenziale terapia, con sforzi che vanno avanti e indietro tra il tentativo di aumentare o diminuire i livelli di interferone”, ha affermato Gallagher. “La mia sensazione è che la sua efficacia come terapia sarà specifica sia per il paziente che per i tempi“.
Per sperimentare questo aspetto, il team di studio ha somministrato l’interferone beta a topi diabetici infetti da coronavirus e ha visto che erano in grado di aumentare SETDB2 e diminuire le citochine infiammatorie.
“Stiamo cercando di capire cosa controlla SETDB2, che è una specie di regolatore principale di molte di queste citochine infiammatorie cui si sente parlare come aumentate nel COVID-19, come IL-1B, TNFalpha e IL- 6″, ha spiegato Gallagher.
“Guardando a monte cosa sta controllando SETDB2, l’interferone è all’estremità superiore, con JaK1 e STAT3 nel mezzo. L’interferone aumenta entrambi, il che aumenta SETDB2 in una sorta di cascata.” Questo è importante, ha aggiunto, perché l’identificazione del percorso presenta altri potenziali modi per colpire l’enzima.
Melvin e Gallagher sperano che i risultati di questo studio informeranno gli studi clinici in corso sull’interferone o altri componenti a valle del percorso, compresi i bersagli epigenetici, per COVID-19. Il loro lavoro evidenzia anche la necessità di comprendere i tempi e la specificità cellulare della terapia e di adattare la sua applicazione alle condizioni di base dei pazienti, in particolare i pazienti con diabete.
“La nostra ricerca sta dimostrando che forse se siamo in grado di indirizzare i pazienti con diabete con l’interferone, specialmente all’inizio della loro infezione, ciò potrebbe effettivamente fare una grande differenza“, ha concluso Melvin.
Diabete e covid19: l’interferone è protettivo o dannoso?
Il nostro sistema immunitario produce interferoni e altre citochine per aiutarci a combattere i virus. Ma nel COVID-19, abbiamo appreso che possono anche contribuire a infiammazioni polmonari dannose e potenzialmente pericolose per la vita.
Prove recenti suggeriscono che l’interferone di tipo III, noto anche come interferone lambda (λ), può combattere l’infezione virale limitando anche il danno infiammatorio. Ciò ha portato a ben due studi clinici per sperimentarli come trattamento per il COVID-19.
Questi test però forniscono un avvertimento: i ricercatori del Boston Children’s Hospital, con collaboratori in Italia, forniscono prove che l’interferone di tipo III aumenta il rischio di “superinfezioni” batteriche pericolose per la vita nel polmone. Queste superinfezioni possono verificarsi sia nell’influenza che nel COVID-19. I ricercatori avvertono che gli interferoni di tipo III somministrati successivamente nel corso del COVID-19 potrebbero fare più male che bene.
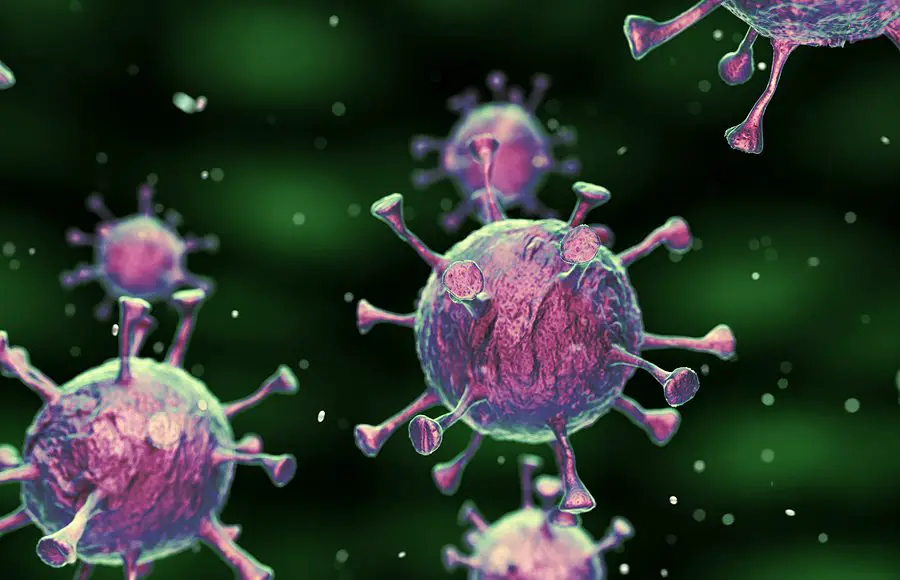
“I nostri dati indicano che il nuovo coronavirus, SARS-CoV-2, inibisce la produzione di interferone nelle vie aeree superiori”, afferma Ivan Zanoni, Ph.D., immunologo presso il Boston Children’s e ricercatore senior dello studio. “Questo indebolisce la risposta immunitaria e aiuta il virus a sopravvivere. Ma quando il virus raggiunge le vie aeree inferiori, c’è una risposta immunitaria esuberante, incluso un aumento degli interferoni di tipo III che riteniamo dannoso”.
Il team ha prima testato campioni di pazienti con COVID-19 grave e controlli sani. L’interferone III non era molto aumentato nei campioni di tampone nasofaringeo dei pazienti. Ma era marcatamente elevato nel loro liquido polmonare.
Successivamente, i ricercatori hanno esposto i topi all’RNA virale sintetico per imitare gli effetti dell’infezione da SARS-CoV-2 nelle vie aeree inferiori. I livelli di interferone III sono aumentati notevolmente nei polmoni degli animali rispetto ai topi di controllo. La continua produzione di interferone III ha impedito ai polmoni di mantenere la loro barriera protettiva superficiale.
Questo, a sua volta, ha reso i topi più suscettibili alle infezioni batteriche letali da Staphylococcus aureus. Gli esperimenti hanno mostrato una maggiore quantità di batteri nei polmoni e una maggiore mortalità rispetto ai topi di controllo.
“C’è ancora molto da capire, ma sembra che l’ubicazione e la tempistica della produzione di interferone siano fondamentali”, afferma Zanoni. “All’inizio dell’infezione da SARS-CoV-2, quando il virus è nelle vie aeree superiori, potrebbe essere importante intervenire con interferoni ricombinanti e altri antivirali. Ma in seguito, quando l’infiammazione aumenta nelle vie aeree inferiori, sarà importante bloccare la cascata di segnali avviata da interferoni e altre citochine infiammatorie, possibilmente con i farmaci antinfiammatori”.