La psilocibina, un composto psicotropo naturale presente in alcune specie di funghi, ha suscitato crescente interesse nella comunità scientifica per le sue potenziali applicazioni terapeutiche nel trattamento di disturbi psichiatrici come la depressione e l’ansia. Partendo da queste premesse, un gruppo di ricercatori dell’Università della California a San Francisco (UCSF) ha intrapreso un’indagine pionieristica per valutare se la psilocibina potesse rappresentare un valido strumento per alleviare la sofferenza dei pazienti affetti da malattia di Parkinson.

Uso della psilocibina nella malattia di Parkinson: primi risultati promettenti
Questa popolazione di pazienti spesso convive con debilitanti disturbi dell’umore che si sommano ai sintomi motori caratteristici della malattia e che, frequentemente, non rispondono in modo soddisfacente ai tradizionali farmaci antidepressivi o ad altre terapie farmacologiche convenzionali.I risultati preliminari di questo studio pilota si sono rivelati sorprendentemente incoraggianti. Non solo i partecipanti hanno dimostrato di tollerare la somministrazione di psilocibina senza manifestare gravi effetti collaterali o un peggioramento dei sintomi neurologici preesistenti – un aspetto cruciale che rappresentava l’obiettivo primario di questa fase iniziale della ricerca – ma hanno anche sperimentato miglioramenti clinicamente significativi in diverse aree chiave.
In particolare, si sono osservati miglioramenti persistenti nell’umore, nelle funzioni cognitive e nelle capacità motorie, i cui effetti benefici si sono protratti per diverse settimane successive alla completa eliminazione del farmaco dall’organismo. Questo studio rappresenta la prima volta in cui una sostanza psichedelica viene formalmente testata su una coorte di pazienti affetti da una malattia neurodegenerativa progressiva.
La dottoressa Ellen Bradley, professoressa associata e direttrice associata del Translational Psychedelic Research Program (TrPR) dell’UCSF, e prima autrice dell’articolo scientifico che riporta questi risultati, ha espresso il suo cauto ottimismo: “Siamo ancora nelle fasi iniziali di questo lavoro di ricerca, ma i risultati preliminari di questo primo studio hanno superato di gran lunga le nostre aspettative iniziali, aprendo scenari terapeutici inesplorati per questa complessa patologia”.
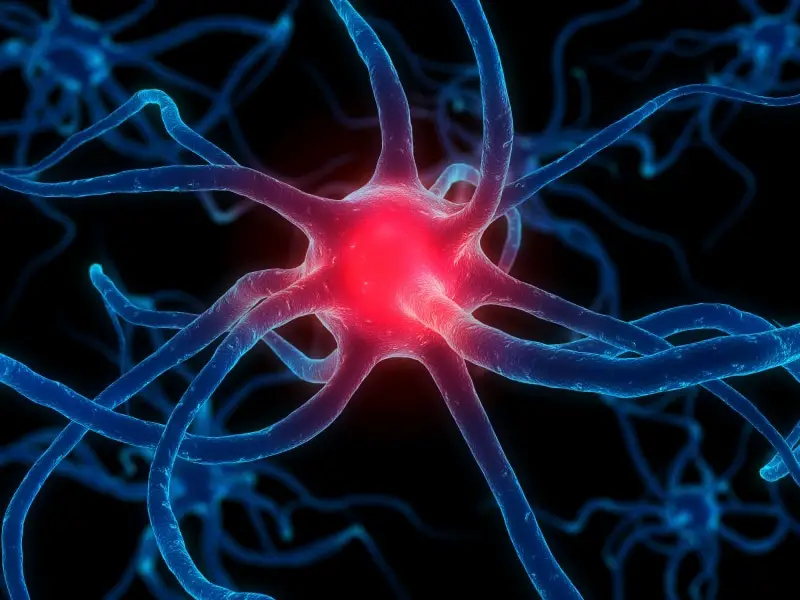
La dottoressa Bradley ha inoltre sottolineato una correlazione spesso sottovalutata nella malattia di Parkinson: “Molte persone non sono consapevoli del fatto che i sintomi depressivi e ansiosi nel Parkinson sono strettamente correlati a un declino fisico più rapido e progressivo. Anzi, i disturbi dell’umore si sono dimostrati un indicatore più potente della qualità della vita complessiva dei pazienti con Parkinson rispetto alla severità dei loro sintomi motori”.
Questo progetto di ricerca innovativo è stato condotto grazie alla collaborazione sinergica tra i ricercatori del Programma TrPR, afferente sia al Dipartimento di Psichiatria e Scienze Comportamentali che al Dipartimento di Neurologia dell’UCSF, evidenziando l’importanza di un approccio interdisciplinare nell’affrontare le sfide complesse poste dalle malattie neurodegenerative.
La malattia di Parkinson: una sfida neurodegenerativa complessa
La malattia di Parkinson, una patologia neurodegenerativa progressiva caratterizzata da disturbi del movimento involontari derivanti da un’attività cerebrale anomala, affligge una significativa porzione della popolazione mondiale, con circa un milione di persone colpite solo negli Stati Uniti. Nonostante la disponibilità di farmaci come la levodopa, in grado di alleviare alcuni dei sintomi motori caratteristici, ad oggi non esistono terapie approvate che possano rallentare la progressione della malattia o, idealmente, invertirne il corso.
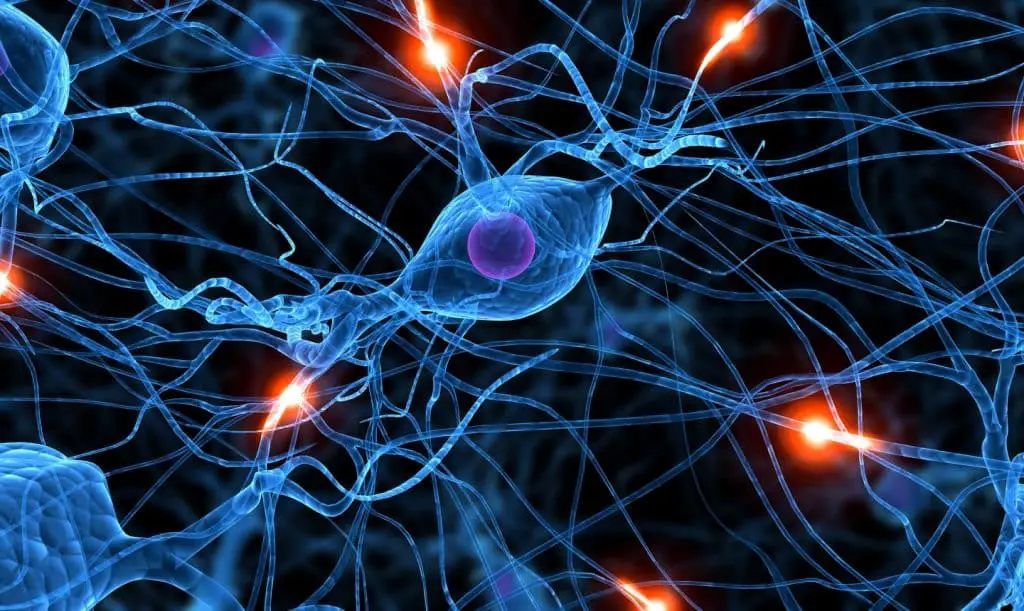
Sebbene i segni fisici precoci più comuni del Parkinson includano tremori e un’andatura strascicata, la dottoressa Bradley ha evidenziato come l’insorgenza di ansia e depressione in pazienti senza una pregressa storia di disturbi psichiatrici spesso preceda di diversi anni la comparsa dei sintomi motori. I meccanismi sottostanti alla scarsa efficacia dei farmaci antidepressivi standard in questa popolazione di pazienti rimangono ancora oggetto di indagine, ma è plausibile che gli sbalzi d’umore rappresentino una parte integrante del processo neurodegenerativo sottostante.
Al fine di valutare la sicurezza e la potenziale efficacia della psilocibina in pazienti affetti da morbo di Parkinson, i ricercatori hanno condotto uno studio pilota coinvolgendo sette uomini e cinque donne con una diagnosi di Parkinson da lieve a moderato. Ai partecipanti è stata somministrata una dose iniziale di 10 mg di psilocibina, seguita, a distanza di due settimane, da una dose più elevata di 25 mg. Parallelamente alla somministrazione del composto psicotropo, i pazienti hanno partecipato a un ciclo di otto sedute di psicoterapia, condotte sia prima che dopo le somministrazioni di psilocibina. Durante lo studio, sono stati attentamente monitorati e valutati i cambiamenti nell’umore, nelle funzioni cognitive e nei sintomi motori dei partecipanti.
Sebbene quasi tutti i partecipanti abbiano manifestato alcuni effetti avversi transitori durante l’assunzione di psilocibina, quali ansia, nausea e un transitorio aumento della pressione sanguigna, questi eventi non sono stati considerati sufficientemente gravi da richiedere un intervento medico specifico, dimostrando una tollerabilità accettabile del farmaco in questo contesto clinico.

I risultati più promettenti dello studio hanno riguardato i miglioramenti significativi osservati dai partecipanti nell’umore, nelle funzioni cognitive e nei sintomi motori, sia durante le visite di controllo effettuate a una settimana che a un mese di distanza dalle somministrazioni di psilocibina. Sorprendentemente, quando il team di ricerca ha valutato nuovamente l’umore dei partecipanti a tre mesi di distanza dalle sessioni con psilocibina, ha riscontrato un ulteriore miglioramento statisticamente significativo, suggerendo una persistenza degli effetti benefici del trattamento.
I ricercatori hanno proposto diverse ipotesi plausibili per spiegare i miglioramenti osservati. Un possibile meccanismo è che l’impatto positivo della psilocibina sull’umore dei pazienti possa aver indirettamente condotto a un miglioramento delle funzioni cognitive e motorie. Ad esempio, un miglioramento del tono dell’umore potrebbe incentivare i pazienti a socializzare maggiormente e a intraprendere attività fisiche, entrambi elementi riconosciuti come cruciali nella gestione del morbo di Parkinson.
Un’altra teoria interessante suggerisce che la psilocibina potrebbe agire su molteplici fronti della patologia, alleviando diversi sintomi della malattia attraverso la riduzione dell’infiammazione a livello cerebrale e la promozione della neuroplasticità. La neuroplasticità, ovvero la capacità del cervello di formare nuove connessioni neurali e di riorganizzare le proprie reti, è un processo fondamentale per la regolazione dell’umore, della cognizione e del movimento, tutte aree significativamente compromesse nel morbo di Parkinson.
Verso studi clinici su larga scala
I risultati incoraggianti emersi da questo studio pilota hanno fornito una solida base per l’avanzamento della ricerca. I ricercatori dell’Università della California a San Francisco (UCSF) sono ora pronti ad avviare uno studio clinico randomizzato e controllato di portata più ampia, con l’obiettivo di reclutare un gruppo di pazienti più numeroso e rappresentativo della diversità clinica del morbo di Parkinson.

Questa seconda fase della ricerca integrerà metodologie avanzate, quali la stimolazione cerebrale non invasiva, la neuroimmagine funzionale e altri strumenti diagnostici sofisticati, per indagare in modo più approfondito l’impatto della psilocibina sui processi patofisiologici chiave della malattia, con particolare attenzione all’infiammazione neuronale e alla neuroplasticità.
Al fine di incrementare la dimensione del campione e di garantire una maggiore generalizzabilità dei risultati, il secondo studio clinico comprenderà una seconda sede di reclutamento presso la prestigiosa Yale University. L’obiettivo complessivo è quello di arruolare un totale di 100 partecipanti, consentendo un’analisi statistica più robusta e la possibilità di identificare potenziali sottogruppi di pazienti che potrebbero beneficiare maggiormente di questo approccio terapeutico innovativo.
Il dottor Joshua Woolley, autore principale dello studio pilota, professore associato presso l’UCSF e direttore del programma TrPR, ha espresso un cauto ma significativo ottimismo riguardo alle implicazioni di questa linea di ricerca: “Nella stragrande maggioranza delle patologie cerebrali, ad oggi, mancano ancora interventi terapeutici in grado di modificare in modo sostanziale il corso della malattia. Spesso, la nostra capacità si limita al trattamento dei sintomi manifesti, senza tuttavia riuscire a influenzare la progressione della patologia sottostante o a prevenire il declino neurologico.

Ora, stiamo assistendo a un potenziale punto di svolta. I risultati preliminari di questo studio sollevano l’entusiasmante possibilità che la psilocibina possa effettivamente possedere la capacità di aiutare il cervello a ripararsi e a innescare meccanismi neuroprotettivi endogeni, aprendo una nuova frontiera nel trattamento del morbo di Parkinson e, potenzialmente, di altre malattie neurodegenerative”.
Lo studio è stato pubblicato su Neuropsychopharmacology.