L’apprendimento del controllo del fuoco ha rappresentato una svolta epocale per le popolazioni umane preistoriche, fornendo loro uno strumento versatile per la cottura dei cibi, l’illuminazione notturna e la protezione dal freddo, tra le molteplici applicazioni. Questa fondamentale abilità affonda le sue radici in un passato remoto, risalente ad almeno un milione di anni fa.

La padronanza del fuoco: una pietra miliare nell’evoluzione umana
Sebbene il fuoco si sia dimostrato un elemento cruciale nel corso della storia umana, la sua importanza si acuiva particolarmente in determinati periodi climatici avversi. L’Ultimo Massimo Glaciale (LGM), ad esempio, il periodo più freddo dell’ultima fase glaciale dell’attuale era glaciale terrestre, sembrerebbe un momento in cui la possibilità di riscaldarsi attorno a un fuoco avrebbe dovuto essere di inestimabile valore.
Paradossalmente, nonostante le temperature estremamente rigide che caratterizzarono quell’epoca, le evidenze archeologiche relative all’utilizzo del fuoco da parte degli esseri umani durante l’Ultimo Massimo Glaciale (LGM), che si estese approssimativamente tra 26.500 e 19.000 anni fa, sono sorprendentemente scarse. In un recente studio, un team di ricercatori ha intrapreso la ricerca di risposte a questo enigmatico vuoto documentale, analizzando i resti di tre antichi focolari scoperti in un sito archeologico situato nell’attuale Ucraina.
Questi focolari sono tutti associati a insediamenti umani nel sito risalenti all’ultimo millennio a.C. e forniscono nuove preziose informazioni sulla pirotecnologia del tardo Paleolitico superiore, un arco temporale di diversi millenni caratterizzati da condizioni glaciali in cui la rarità dei focolari nei reperti archeologici appare inspiegabile.

“Sappiamo che gli incendi erano diffusi sia prima che dopo questo periodo, ma ci sono poche prove risalenti al culmine dell’era glaciale”, afferma il coautore dello studio William Murphree, geoarcheologo presso l’Università dell’Algarve in Portogallo. Ricerche precedenti hanno ampiamente dimostrato il ruolo cruciale che il fuoco svolgeva nella vita delle popolazioni del Paleolitico superiore, rendendo possibili attività vitali che sarebbero state difficili o addirittura impossibili senza il suo ausilio.
“Il fuoco non serviva solo a riscaldarsi; era essenziale anche per cucinare, costruire utensili e organizzare riunioni sociali”, sottolinea il coautore Philip Nigst, archeologo presso l’Università di Vienna in Austria. L’LGM comportò un “rapido deterioramento climatico” in Europa, osservano i ricercatori, con condizioni estremamente fredde e aride che portarono alla riduzione degli habitat disponibili e all’isolamento geografico delle popolazioni umane. In un contesto così ostile, appare illogico ipotizzare una volontaria riduzione nell’uso del fuoco da parte di queste comunità.
Limitazioni ambientali, distruzione di evidenze o bias di ricerca
Diverse ipotesi sono state avanzate per spiegare la scarsità di testimonianze archeologiche relative all’uso del fuoco durante l’Ultimo Massimo Glaciale. Una possibile spiegazione risiede nelle condizioni ambientali estreme dell’epoca. Il freddo intenso potrebbe aver ostacolato significativamente la crescita degli alberi nelle vaste steppe e praterie che caratterizzavano il paesaggio europeo, limitando di conseguenza la disponibilità di legna da ardere, la principale fonte di combustibile per l’accensione dei fuochi.

In alternativa, è possibile che le popolazioni umane abbiano continuato ad accendere fuochi con la stessa frequenza, se non maggiore, per fronteggiare le rigide temperature, ma che le condizioni ambientali avverse durante e dopo l’LGM abbiano portato alla distruzione della maggior parte delle prove archeologiche, rendendo difficile la loro individuazione e conservazione fino ai giorni nostri.
Infine, è stata suggerita anche una prospettiva metodologica: la scarsità di focolari dell’LGM potrebbe non riflettere una reale diminuzione del loro utilizzo, ma piuttosto essere un’illusione derivante da un moderno pregiudizio di pubblicazione, con una potenziale sottorappresentazione di siti risalenti a questo periodo nelle riviste scientifiche e nei database archeologici.
In questo contesto di incertezza interpretativa, la scoperta e l’analisi dettagliata di numerosi focolari risalenti all’LGM assumono un’importanza cruciale. Tali ritrovamenti non solo possono fornire preziose informazioni sulle antiche pratiche legate al fuoco, ma potrebbero anche offrire indizi significativi per comprendere l’apparente rarità di focolari in questo specifico periodo climatico.
Il team di ricerca si è concentrato sullo studio di tre focolari precedentemente portati alla luce nel sito di Korman’ 9, situato lungo il corso del fiume Dniester in Ucraina. Questi manufatti sono stati sottoposti a una rigorosa analisi attraverso una serie di tecniche geoarcheologiche avanzate, con l’obiettivo di ricostruire dettagli a lungo perduti sui fuochi accesi decine di migliaia di anni fa dalle popolazioni umane che abitavano la regione.
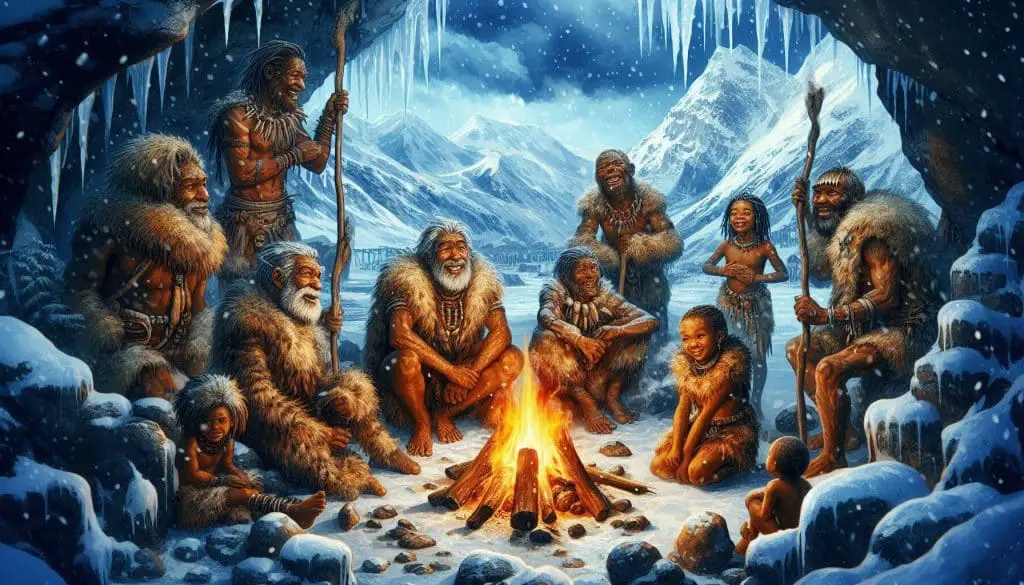
Attraverso l’impiego di analisi microstratigrafiche, micromorfologiche e colorimetriche, i ricercatori sono stati in grado di determinare che i resti analizzati appartenevano a focolari piatti e aperti, tipologie di strutture in cui le persone bruciavano prevalentemente legna come combustibile. Nonostante la loro apparente semplicità costruttiva, questi fuochi erano in grado di riscaldare il terreno sottostante fino a temperature elevate, raggiungendo i 600 gradi Celsius.
Questa temperatura suggerisce che la combustione avveniva a livelli termici ancora superiori, indicando una notevole competenza pirotecnica da parte delle antiche popolazioni, soprattutto considerando il contesto di sconvolgimenti climatici di tale portata. L’analisi dei frammenti di carbone rinvenuti, sebbene non abbondanti in termini di dimensioni, ha rivelato una predominanza di legno di abete rosso come principale fonte di combustibile utilizzata per alimentare questi fuochi.
Inoltre, i focolari contenevano anche tracce di ossa animali, la cui presenza rimane ancora oggetto di indagine. Come spiega la coautrice Marjolein Bosch, zooarcheologa presso l’Università di Vienna, l’Accademia austriaca delle scienze e il Museo di storia naturale di Vienna, la ragione di questa commistione di resti organici all’interno dei focolari non è ancora del tutto chiara e richiederà ulteriori approfondimenti per essere pienamente compresa.
Resti ossei animali nei focolari: combustibile intenzionale o residuo accidentale?
Un aspetto interessante emerso dall’analisi dei focolari del sito di Korman’ 9 riguarda la presenza di ossa animali al loro interno. Alcune di queste ossa mostrano segni di essere state esposte a temperature superiori a 650 gradi Celsius durante la combustione. Come spiega la dottoressa Bosch, l’équipe di ricerca sta attualmente conducendo indagini approfondite per chiarire la natura di questa presenza.

Se queste ossa siano state intenzionalmente utilizzate come combustibile, rappresentando una risorsa energetica alternativa in un ambiente potenzialmente povero di legna, oppure se la loro combustione sia stata un evento accidentale, magari legato allo smaltimento di resti di animali cacciati e consumati sul sito. La distinzione tra queste due ipotesi potrebbe fornire importanti indizi sulle strategie di sussistenza e sull’utilizzo delle risorse da parte delle antiche popolazioni che frequentavano Korman’ 9.
Un’ulteriore osservazione significativa riguarda le differenze riscontrate tra i tre focolari analizzati. Questa variabilità strutturale potrebbe riflettere diverse ipotesi sull’occupazione del sito nel corso del tempo. Una possibilità è che i tre focolari rappresentino episodi di insediamento separati, avvenuti magari a distanza di settimane, mesi o addirittura secoli l’uno dall’altro, suggerendo un utilizzo intermittente del sito da parte di gruppi umani diversi o della stessa comunità in momenti successivi.
In alternativa, le differenze potrebbero non essere legate a separazioni temporali, ma piuttosto a una specializzazione funzionale dei focolari all’interno di una singola fase di occupazione. In questo scenario, individui appartenenti alla stessa comunità avrebbero potuto utilizzare focolari distinti per scopi specifici, come la cottura di determinati alimenti, la lavorazione di materiali particolari o attività stagionali diverse.
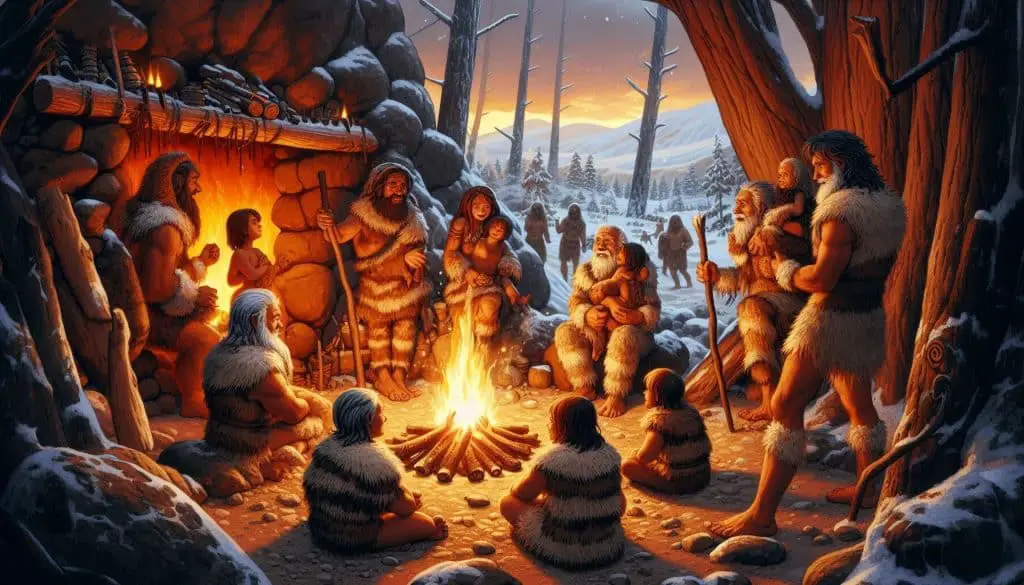
Come sottolinea il dottor Nigst, le antiche popolazioni avevano una profonda conoscenza e un controllo sofisticato del fuoco, sapendolo adattare a diverse esigenze. I risultati dello studio sembrano anche suggerire che i cacciatori-raccoglitori che frequentavano Korman’ 9 utilizzavano lo stesso sito in diverse stagioni durante i loro cicli migratori annuali, implicando una familiarità con le risorse locali e una pianificazione dei loro spostamenti in base alla disponibilità stagionale.
Nonostante le preziose informazioni ricavate dall’analisi dei focolari di Korman’ 9, il mistero che circonda la generale scarsità di focolari risalenti all’Ultimo Massimo Glaciale in altri siti contemporanei rimane in gran parte irrisolto. Come si interroga il dottor Murphree, è possibile che la maggior parte delle prove di utilizzo del fuoco sia stata irrimediabilmente distrutta dal tipico ciclo di gelo e disgelo che caratterizzava il terreno durante l’era glaciale, rendendo estremamente difficile la conservazione delle strutture dei focolari e dei relativi reperti organici?

Oppure, come aggiunge il dottor Nigst, la ragione potrebbe risiedere in una reale diminuzione dell’uso del fuoco da parte delle popolazioni umane durante quel periodo, forse a causa della scarsità di combustibile disponibile nell’ambiente circostante? In questo scenario, le comunità umane avrebbero potuto fare affidamento su altre soluzioni tecnologiche per far fronte al freddo e alle altre necessità, sviluppando strategie alternative al tradizionale utilizzo del fuoco. La risposta a queste domande cruciali richiederà ulteriori ricerche e l’analisi di un numero maggiore di siti archeologici risalenti all’enigmatico periodo dell’Ultimo Massimo Glaciale.
Lo studio è stato pubblicato su Geoarchaeology.