Una recente ricerca condotta da un consorzio di prestigiose istituzioni accademiche, tra cui Columbia University, Vanderbilt University e Johns Hopkins University, ha portato alla luce una correlazione allarmante tra la perdita dell’udito e l’insorgenza di demenza nella popolazione anziana. Attraverso sofisticati modelli statistici applicati a vasti insiemi di dati demografici, il team di ricerca ha stimato che circa un terzo di tutti i nuovi casi di demenza diagnosticati negli anziani possa essere attribuito alla preesistenza di problemi uditivi. Questa scoperta sottolinea la potenziale importanza della perdita dell’udito come fattore di rischio significativo per il declino cognitivo.

L’impatto crescente della demenza e il ruolo dei fattori di rischio modificabili: un focus sulla perdita dell’udito
La prevalenza globale della demenza è prevista triplicare nei prossimi decenni, rappresentando una crescente sfida per la sanità pubblica a livello mondiale. In questo contesto, gli sforzi della ricerca si sono progressivamente concentrati sull’identificazione e la gestione dei fattori di rischio modificabili, ovvero quelle condizioni o abitudini che possono essere potenzialmente alterate per ridurre il rischio di sviluppare demenza. Tra questi fattori, la perdita dell’udito, una condizione che affligge oltre i due terzi della popolazione anziana negli Stati Uniti, è emersa come un potenziale elemento correlato al declino cognitivo, suscitando un crescente interesse nella comunità scientifica.
Le stime precedenti relative alla percentuale di demenza associata alla perdita dell’udito negli Stati Uniti presentavano una notevole variabilità, oscillando tra il 2% e il 19%. Questa eterogeneità nei risultati è stata in parte attribuita alle diverse metodologie impiegate per la misurazione della funzione uditiva. Molti studi si basavano sull’autovalutazione della perdita dell’udito da parte dei partecipanti, un approccio che tende a sottostimare il deterioramento uditivo clinicamente significativo, specialmente nella popolazione anziana. Inoltre, rimaneva incertezza riguardo alla possibilità di ridurre il rischio di demenza attraverso interventi mirati al trattamento della perdita dell’udito.

Per affrontare queste lacune nella conoscenza, i ricercatori hanno condotto uno studio di coorte prospettico con l’obiettivo primario di calcolare la frazione di demenza incidente nella popolazione anziana attribuibile alla perdita dell’udito. Un obiettivo secondario era analizzare le potenziali differenze in questa associazione in base a variabili demografiche cruciali come età, sesso, razza e, soprattutto, il metodo utilizzato per la misurazione della perdita dell’udito. L’analisi si è basata sui dati di 2.946 adulti residenti nella comunità, con un’età compresa tra i 66 e i 90 anni e senza diagnosi di demenza al basale.
Questi partecipanti facevano parte dello studio neurocognitivo “Atherosclerosis Risk in Communities” (ARIC-NCV), un’indagine multicentrica che ha coinvolto individui provenienti da quattro stati diversi. La raccolta dei dati si è svolta tra il 2011 e il 2019, con una valutazione audiologica completa effettuata durante la sesta visita di follow-up, nel periodo 2016-2017. Questo approccio metodologico rigoroso ha permesso di ottenere stime più precise e di esplorare in dettaglio la complessa relazione tra perdita dell’udito e demenza nella popolazione anziana.
Un approccio rigoroso
Nell’ambito di questa approfondita indagine sulla relazione tra funzione uditiva e rischio di demenza, la perdita dell’udito è stata valutata attraverso due metodologie complementari, al fine di ottenere una comprensione più completa della condizione dei partecipanti. Da un lato, è stata impiegata l’audiometria tonale pura, un test audiologico obiettivo e standardizzato considerato il gold standard per la valutazione quantitativa della soglia uditiva a diverse frequenze. Questo esame permette di identificare e quantificare con precisione il grado di perdita uditiva in ciascun orecchio.

Dall’altro lato, è stata inclusa una valutazione soggettiva della perdita dell’udito attraverso questionari di autovalutazione, consentendo di catturare la percezione individuale dei partecipanti riguardo alle proprie capacità uditive e alle eventuali difficoltà incontrate nella vita quotidiana. La diagnosi di demenza, elemento cruciale per l’analisi, è stata determinata attraverso l’applicazione di un algoritmo standardizzato e validato.
Questo algoritmo integrava i risultati di una batteria completa di test neuropsicologici, volti a valutare diverse aree della funzione cognitiva, le informazioni raccolte durante interviste strutturate con informatori affidabili (solitamente familiari o conviventi dei partecipanti) e la revisione accurata delle cartelle cliniche e della storia medica di ciascun individuo. Questo approccio multimodale ha garantito una diagnosi di demenza il più accurata e affidabile possibile.
L’analisi dei dati audiometrici ha rivelato una prevalenza significativamente elevata di perdita uditiva clinicamente significativa nella coorte studiata. Ben il 66,1% dei partecipanti ha mostrato, al momento della valutazione audiologica, un grado di ipoacusia tale da essere considerato clinicamente rilevante. Durante il periodo di follow-up, un’analisi comparativa ha evidenziato una marcata differenza nell’incidenza di demenza tra i partecipanti con e senza perdita uditiva.

Nello specifico, il 9,9% dei partecipanti che presentavano una perdita dell’udito al basale ha sviluppato demenza nel corso dello studio. Al contrario, solo il 4,7% dei partecipanti con una funzione uditiva considerata nella norma ha ricevuto una diagnosi di demenza durante lo stesso periodo.Questa differenza percentuale suggerisce una potenziale associazione tra la preesistenza di problemi uditivi e un aumentato rischio di sviluppare demenza in età avanzata.
Attraverso l’applicazione di sofisticati modelli statistici a livello di popolazione, i ricercatori hanno stimato che una considerevole proporzione dei casi di demenza osservati nella coorte potrebbe essere statisticamente associata alla presenza di qualsiasi grado di perdita uditiva misurata oggettivamente tramite audiometria. La frazione attribuibile alla popolazione (PAF) stimata per la demenza associata a qualsiasi perdita uditiva audiometrica è risultata pari al 32,0%, con un intervallo di confidenza al 95% compreso tra l’11,0% e il 46,5%.
Questo dato suggerisce che, a livello di popolazione, quasi un terzo dei casi di demenza negli anziani potrebbe essere potenzialmente collegato alla preesistenza di problemi uditivi rilevati attraverso test audiometrici. Un’analisi più dettagliata ha inoltre permesso di distinguere l’impatto di diversi gradi di perdita uditiva sul rischio di demenza.

È emerso che la perdita uditiva lieve (definita come una perdita uditiva compresa tra 26 e 40 decibel) presentava una frazione attribuibile alla popolazione del 16,2% (IC 95%, 4,2%-24,2%), indicando che una parte non trascurabile dei casi di demenza potrebbe essere associata anche a una compromissione uditiva di grado relativamente moderato. In modo simile, la perdita uditiva moderata o superiore (definita come una perdita uditiva superiore a 40 decibel) mostrava una frazione attribuibile alla popolazione del 16,6% (IC 95%, 3,9%-24,3%), suggerendo un contributo simile al carico di demenza nella popolazione anziana. Questi risultati sottolineano l’importanza di considerare anche i gradi più lievi di perdita uditiva come potenziali fattori di rischio per il declino cognitivo e la demenza nella popolazione anziana.
Evidenze e incidenze statistiche
Nell’ambito di un’analisi più approfondita volta a esplorare le potenziali variazioni nell’associazione tra perdita dell’udito e demenza in specifici sottogruppi demografici, i ricercatori hanno focalizzato la loro attenzione sui partecipanti di età pari o superiore a 75 anni. I modelli statistici applicati a questo specifico gruppo di anziani suggeriscono che una porzione considerevole dei casi di demenza potrebbe essere collegata alla preesistenza di problemi uditivi. Le stime indicano che fino a circa il 31% dei casi di demenza in questo sottogruppo potrebbe essere attribuibile alla perdita dell’udito.
È tuttavia fondamentale interpretare questo risultato alla luce dell’ampio intervallo di confidenza al 95%, che spazia da un valore negativo di -6% fino a un valore positivo del 53%. Questa ampia escursione dell’intervallo di confidenza sottolinea una notevole incertezza statistica, suggerendo che la reale proporzione di casi di demenza collegati alla perdita dell’udito in questo gruppo di età potrebbe essere significativamente inferiore o addirittura non esistere.

Analisi stratificate per sesso ed etnia hanno rivelato tendenze simili a quelle osservate per la popolazione anziana nel suo complesso, sebbene anch’esse caratterizzate da una notevole incertezza statistica. Per quanto riguarda il sesso, le stime suggeriscono che circa il 31% dei casi di demenza nelle donne potrebbe essere associato alla perdita dell’udito, con un intervallo di confidenza al 95% compreso tra il 6% e il 47%. Per i partecipanti di etnia bianca, la stima della frazione di demenza potenzialmente collegata alla perdita dell’udito si attesta intorno al 28%, con un intervallo di confidenza al 95% che va da -6% a 50%.
È importante notare che gli ampi intervalli di confidenza, che in alcuni casi includono lo zero e si sovrappongono tra i diversi gruppi (uomini e donne, diverse etnie), non hanno permesso di evidenziare differenze statisticamente significative nell’associazione tra perdita dell’udito e demenza tra questi sottogruppi demografici specifici.
Contrariamente ai risultati ottenuti con la misurazione oggettiva dell’udito tramite audiometria, l’analisi della perdita dell’udito auto-riferita dai partecipanti ha mostrato un’associazione con un rischio inferiore di sviluppare demenza, sebbene questa associazione non abbia raggiunto la significatività statistica.

A causa di un hazard ratio inferiore a 1 (che indica una potenziale riduzione del rischio, seppur non statisticamente robusta), non è stata calcolata alcuna frazione attribuibile alla popolazione per la perdita dell’udito auto-riferita. Questa discrepanza tra i risultati ottenuti con le misure oggettive e soggettive dell’udito sottolinea l’importanza di utilizzare metodologie di valutazione accurate e affidabili nello studio della relazione tra funzione uditiva e declino cognitivo.
I risultati complessivi di questa analisi evidenziano in modo chiaro come differenti metodi di misurazione della perdita dell’udito possano condurre a stime sostanzialmente diverse del carico di demenza attribuibile a questa condizione. La discrepanza tra i risultati ottenuti con l’audiometria tonale pura (misurazione oggettiva) e l’autovalutazione della perdita dell’udito (misurazione soggettiva) suggerisce che quest’ultima potrebbe non essere una misura sufficientemente sensibile o specifica per catturare accuratamente la perdita uditiva clinicamente rilevante, specialmente nella popolazione anziana.
Di conseguenza, la ricerca futura in questo campo potrebbe trarre significativo beneficio dal dare priorità all’impiego di valutazioni oggettive dell’udito, come l’audiometria, al fine di migliorare la precisione e l’affidabilità delle stime del rischio di demenza correlata alla perdita uditiva e di comprendere meglio la reale entità di questa associazione a livello di popolazione.
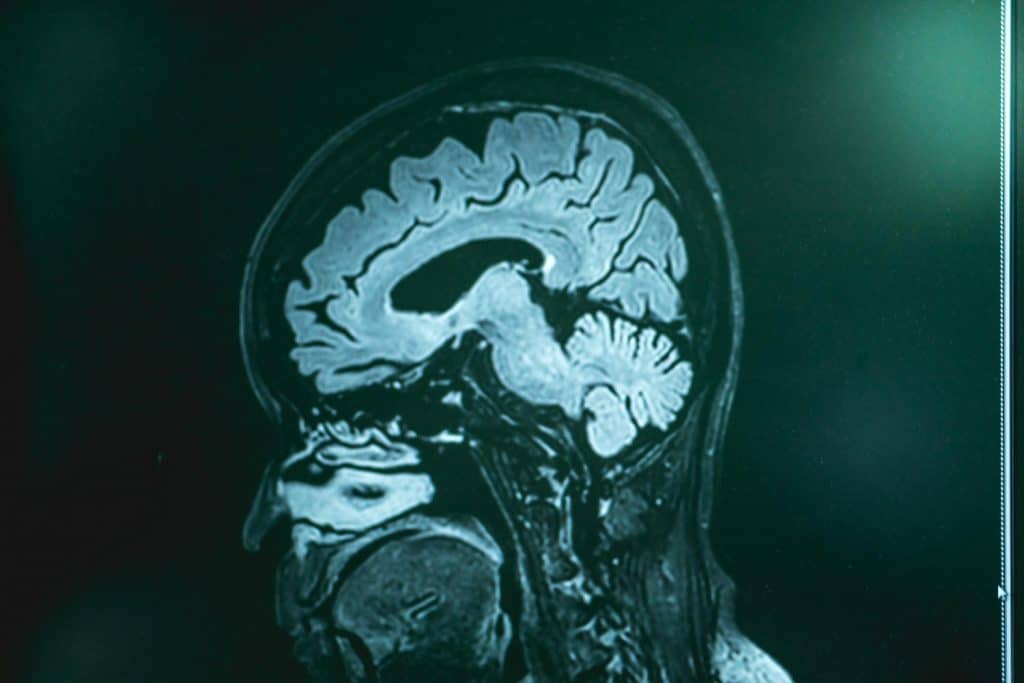
È cruciale sottolineare un’importante limitazione metodologica di questo studio: la funzione uditiva dei partecipanti è stata valutata in un singolo punto temporale, prima dell’insorgenza di eventuali segni di demenza. Pertanto, lo studio non ha monitorato l’evoluzione dell’udito o della perdita uditiva nel tempo. Ciò che viene descritto come “perdita dell’udito” nel contesto di questa ricerca si riferisce a una capacità uditiva inferiore alla norma misurata in un momento specifico, precedente alla diagnosi di demenza.
Questa natura trasversale della misurazione dell’udito non permette di stabilire una relazione causale diretta tra la perdita dell’udito e lo sviluppo della demenza, ma evidenzia un’associazione temporale che necessita di ulteriori indagini longitudinali per comprenderne appieno la dinamica e la potenziale direzionalità.
Lo studio: “Population Attributable Fraction of Incident Dementia Associated With Hearing Loss”, è stato pubblicato su JAMA Otolaryngology—Head & Neck Surgery.