Il professore associato junior Kazuo Takayama (Dipartimento di crescita e differenziazione cellulare) e un team collaborativo di ricercatori in Giappone hanno recentemente caratterizzato il SARS-CoV-2 raccolto da un paziente Covid19 persistente per identificare i fattori critici responsabili della generazione di nuovi ceppi mutanti.
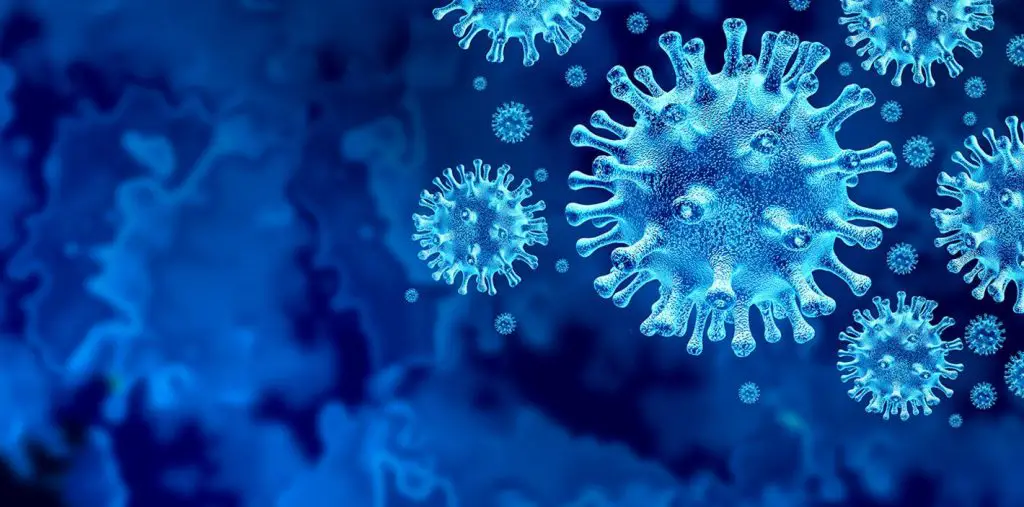
Covid19: si prevede un’evoluzione dell’infezione
La pandemia di COVID19, causata da COVID-19, è stata in parte dovuta alla rapida evoluzione virale che ha generato continuamente nuove varianti. Sebbene sia noto che molteplici fattori contribuiscono alla rapida comparsa di ceppi mutanti, i principali fattori che contribuiscono rimangono poco chiari.
In questo studio , accettato per la pubblicazione su iScience , i ricercatori hanno raccolto campioni di siero e isolati virali da un paziente immunocompromesso che era stato persistentemente infettato dalla variante omicron BF.5 di Covid19 per diversi mesi per tracciarne l’evoluzione e identificare potenzialmente fattori cruciali responsabile degli effetti diffusi di questo virus respiratorio.
A causa dell’immunosoppressione cronica del paziente come parte del trattamento della fascite eosinofila, i ricercatori hanno rilevato nei campioni solo bassi livelli di anticorpi contro Covid19. Al contrario, sebbene abbiano rilevato granuli citolitici nei sieri raccolti dal paziente, suggerendo che le cellule T NK (natural killer) e CD8 + fossero probabilmente funzionanti, il gruppo di ricerca ha concluso che queste cellule immunitarie da sole, senza una sufficiente produzione di anticorpi da parte delle cellule B, erano incapace di eliminare con successo il virus dal paziente.
I ricercatori hanno poi analizzato i genomi virali isolati dai campioni di tampone mediante metodi di sequenziamento di nuova generazione. Sorprendentemente, mentre il genoma virale è mutato in 10 posizioni tra il primo e i due punti temporali di campionamento (giorni 0 e 17), è cambiato rispettivamente in 27 e 37 posizioni durante il secondo e il terzo intervallo tra la raccolta del campione (giorni 18-56 e 57–119), suggerendo che il virus potrebbe acquisire mutazioni più rapidamente se lasciato senza controllo per più di due mesi.
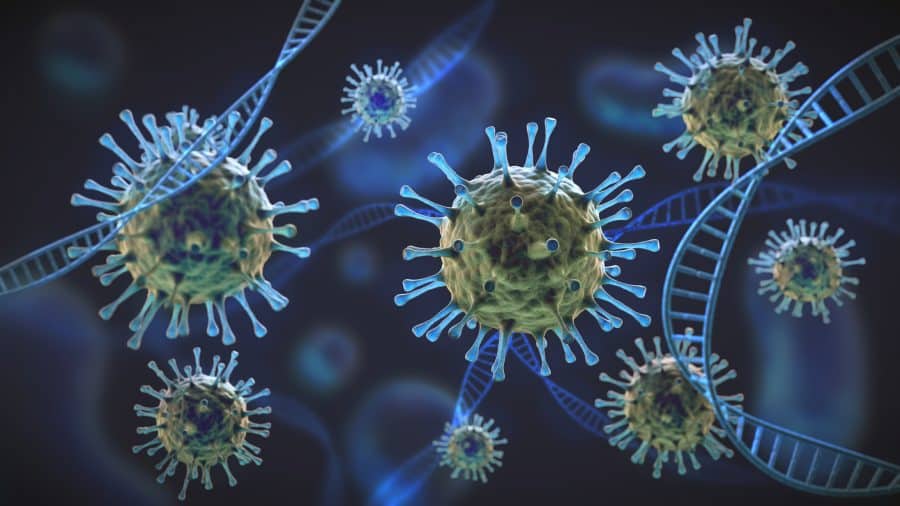
Utilizzando la loro esperienza nella tecnologia degli organoidi, i ricercatori hanno esaminato la capacità replicativa dei virus e i loro effetti sulle cellule ospiti infettando organoidi polmonari derivati da cellule iPS umane con ciascun isolato virale. Hanno rilevato livelli simili di espressione genica virale e di produzione tra gli isolati, dimostrando che l’infettività era generalmente inalterata durante l’intero corso di un’infezione persistente da Covid19
Inoltre, i ricercatori hanno esaminato la sensibilità al farmaco antivirale, remdesivir, e alla terapia con anticorpi proteici anti-spike, sotrovimab, utilizzando organoidi polmonari. Tutti gli isolati virali hanno mostrato un’elevata suscettibilità al trattamento con remdesivir ma erano ampiamente resistenti alla terapia con anticorpi, poiché tutti contenevano mutazioni della proteina spike (G339D o R346T) note per renderli resistenti a sotrovimab. Questi risultati indicano che l’infettività e la sensibilità ai trattamenti antivirali sono rimaste per lo più invariate nonostante l’acquisizione di molteplici mutazioni durante l’infezione persistente.
Per determinare se lo studio degli isolati virali di un paziente affetto da infezione persistente da COVID-19 può aiutare a prevedere l’evoluzione virale, i ricercatori si sono concentrati sulla sequenza aminoacidica della proteina S e hanno eseguito analisi filogenetiche comparative con i ceppi emergenti di Covid19 che si presentano in Il mondo reale.
In particolare, diverse mutazioni (D574N, S975N, S1003I e A1174V), relativamente rare prima della comparsa di BF.5, sono state acquisite durante l’infezione persistente, indicando che potrebbero avere maggiori probabilità di emergere dal ceppo BF.5. Il gruppo di ricerca ha quindi testato questa idea esaminando la frequenza di queste mutazioni nei ceppi che compaiono dopo il ceppo BF.5.
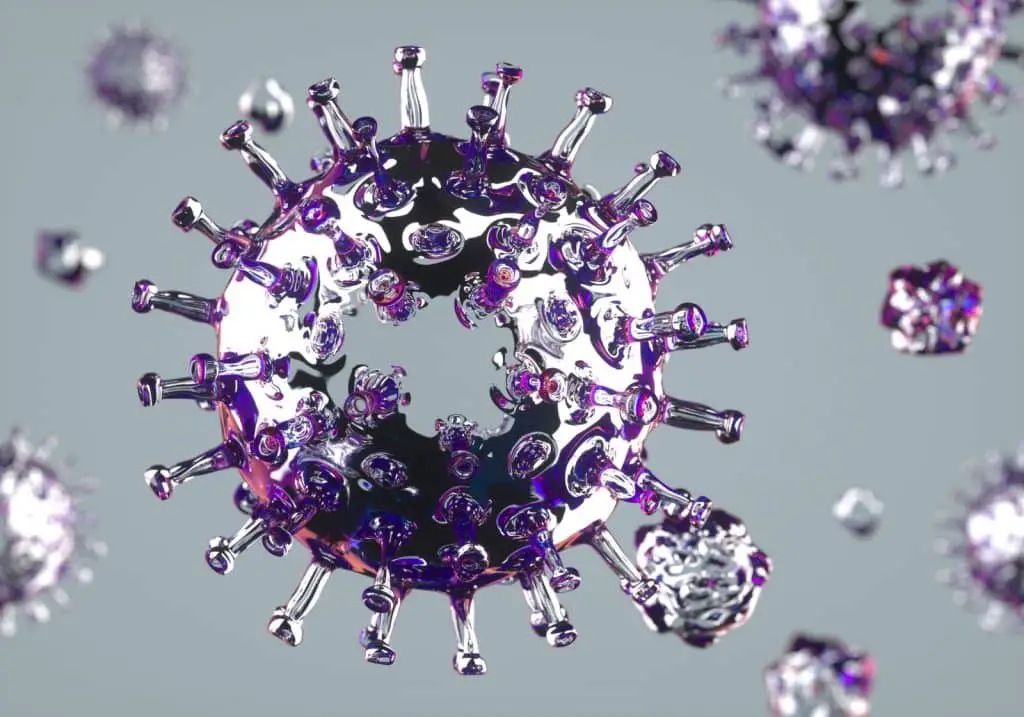
Sorprendentemente, le mutazioni D574N e S1003I sono state rilevate in più dell’1% dei ceppi discendenti emergenti da BA.5 (BA.5.24, BA.5.2.36, CG.1, BF.7.26 e BQ.1.1.21), quindi dimostrando le implicazioni potenziali e reali dell’analisi dell’evoluzione virale in pazienti persistentemente infetti.
In sintesi, lo studio illustra il potenziale dello studio di come i virus cambiano nel tempo nei pazienti con infezioni persistenti per prevedere come potrebbero evolversi nel mondo reale. Tuttavia, è fondamentale notare che è necessario includere ulteriori pazienti con infezione persistente per determinare l’applicabilità generale di tali risultati poiché le differenze individuali potrebbero potenzialmente distorcere l’evoluzione virale.
Numero elevato di infezioni persistenti da COVID-19 nella popolazione generale
Uno studio condotto dall’Università di Oxford ha scoperto che un’elevata percentuale di infezioni da COVID-19 nella popolazione generale porta a infezioni persistenti che durano un mese o più. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Nature.
Si è a lungo pensato che le infezioni prolungate da COVID-19 in individui immunocompromessi possano essere state la fonte delle molteplici nuove varianti emerse durante la pandemia di coronavirus e seminare ondate successive di infezione, comprese le varianti alfa e omicron. Ma fino ad ora, la prevalenza delle infezioni persistenti da COVID-19 nella popolazione generale e il modo in cui il virus si evolve in queste situazioni rimanevano sconosciuti.
Per indagare su questo, i ricercatori hanno utilizzato i dati dell’Office for National Statistics COVID Infection Survey (ONS-CIS), che ha testato i partecipanti circa una volta al mese.
Degli oltre 90.000 partecipanti, 3.603 hanno fornito due o più campioni positivi tra novembre 2020 e agosto 2022 in cui è stato sequenziato il virus. Di questi, 381 individui sono risultati positivi alla stessa infezione virale per un periodo di un mese o più.
All’interno di questo gruppo, 54 individui hanno avuto un’infezione persistente durata almeno due mesi. I ricercatori stimano che tra una su mille e una su 200 (0,1-0,5%) di tutte le infezioni possano diventare persistenti e durare almeno 60 giorni.

In alcuni casi, gli individui sono rimasti infettati da varianti virali che si erano estinte nella popolazione generale. Al contrario, i ricercatori hanno scoperto che la reinfezione con la stessa variante era molto rara, probabilmente a causa dello sviluppo dell’immunità dell’ospite verso quella variante e della riduzione della frequenza della variante a livelli molto bassi dopo pochi mesi.
Delle 381 infezioni persistenti , 65 sono state sottoposte a tre o più test PCR nel corso dell’infezione. La maggior parte (82%) di questi individui ha dimostrato una dinamica virale di rimbalzo, sperimentando dinamiche di carica virale alta, poi bassa, poi alta. Secondo i ricercatori, ciò dimostra che il virus può mantenere la capacità di replicarsi attivamente durante infezioni prolungate.
Nello studio, le persone con infezioni persistenti avevano il 55% in più di probabilità di riferire di avere sintomi COVID a lungo termine per più di 12 settimane dall’inizio dell’infezione rispetto alle persone con infezioni più tipiche.
Alcuni individui hanno mostrato un numero estremamente elevato di mutazioni, comprese mutazioni che definiscono nuove varianti di coronavirus, alterano i siti bersaglio per gli anticorpi monoclonali e introducono modifiche alla proteina spike del coronavirus. Tuttavia, la maggior parte degli individui non presentava un gran numero di mutazioni, suggerendo che non tutte le infezioni persistenti saranno una potenziale fonte di nuove varianti preoccupanti.
Il co-autore principale dello studio, il dottor Mahan Ghafari (Pandemic Sciences Institute, Dipartimento di Medicina di Nuffield, Università di Oxford), ha dichiarato: “Le nostre osservazioni evidenziano la continua importanza della sorveglianza genomica basata sulla comunità sia per monitorare l’emergere che la diffusione di nuove varianti, ma anche per acquisire una comprensione fondamentale della storia naturale e dell’evoluzione dei nuovi agenti patogeni e delle loro implicazioni cliniche per i pazienti”.
La co-autrice principale, la Dott.ssa Katrina Lythgoe (Dipartimento di Biologia e Istituto di Scienze Pandemiche, Università di Oxford) ha dichiarato: “Sebbene il legame tra persistenza virale e COVID lungo possa non essere causale, questi risultati suggeriscono che le infezioni persistenti potrebbero contribuire alla patofisiologia del virus”. COVID lungo. In effetti, sono stati suggeriti molti altri possibili meccanismi che contribuiscono al COVID lungo, tra cui infiammazione, danno agli organi e microtrombosi.
Pazienti immunocompromessi e infezioni da COVID: chi è a rischio?
All’inizio della pandemia, i medici hanno notato che alcuni pazienti immunocompromessi presentavano infezioni persistenti da SARS-CoV-2, alcune delle quali duravano settimane o mesi alla volta.
Ciò ha sollevato preoccupazioni sul fatto che uno di questi casi potrebbe essere la fonte di una variante virale emergente che ha beneficiato di una lunga battaglia con il sistema immunitario .
Uno studio prospettico, “SARS-CoV-2 shedding and Evolution in Patients who was immunocompromised durante il periodo omicron: un’analisi multicentrica e prospettica”, pubblicato sulla rivista Lancet Microbe, fornisce maggiore chiarezza su quali popolazioni di pazienti sono a maggior rischio di infezioni prolungate – e suggerisce che questa paura è probabilmente ingiustificata.
Lo studio, condotto da Adam Lauring, MD, Ph.D., della Divisione di malattie infettive della Michigan Medicine, fa parte del più ampio studio IVY Network sponsorizzato dal CDC e diretto dalla Vanderbilt University.
Il team collaborativo ha seguito 150 pazienti immunocompromessi con infezioni da COVID provenienti da cinque sistemi sanitari degli Stati Uniti nel 2022.
Ogni paziente è stato esaminato e testato utilizzando tamponi nasali raccolti dall’inizio dell’infezione da SARS-CoV-2 fino a quando non sono risultati negativi.
“Stavamo esaminando specificamente chi era a rischio di infezione prolungata, in modo tale da non eliminare mai il virus”, ha affermato Lauring.
I partecipanti allo studio presentavano una serie diversificata di condizioni immunocompromettenti, che andavano da persone con tumori a cellule B o che ricevevano terapia anti-cellule B; soggetti sottoposti a trapianto di organi solidi o cellule staminali; persone che vivono con l’AIDS; e quelli con tumori a cellule non B e condizioni autoimmuni o autoinfiammatorie.
Il team ha scoperto che solo il 25% dei pazienti è risultato positivo utilizzando il test PCR altamente sensibile, standard di riferimento, per 21 giorni o più dopo l’insorgenza della malattia.
Solo l’8% è risultato positivo al virus vivo per 21 giorni o più. Il tempo mediano per l’ultimo test positivo complessivo è stato di nove giorni.

“A differenza di molti casi segnalati, abbiamo riscontrato che pochissime persone avevano un’infezione prolungata”, ha affermato Lauring.
Nello specifico, le persone affette da AIDS e quelle con tumori a cellule B, come alcune leucemie e linfomi, avevano maggiori probabilità di contrarre infezioni prolungate rispetto ai pazienti con malattie autoimmuni o tumori a cellule non B. E dei 59 pazienti arruolati con un trapianto di organo solido con immunosoppressione delle cellule T, solo uno ha avuto un’infezione che è durata più di 56 giorni.
L’infezione estesa sembrava anche coincidere con alcune terapie immunosoppressori.
I pazienti trattati con rituximab o terapia CAR-T, che prende di mira le cellule B, avevano maggiori probabilità di avere infezioni di più lunga durata, sottolineando l’importanza degli anticorpi (prodotti dalle cellule B ) per l’immunità.
È importante sottolineare che il team osserva anche che le mutazioni all’interno del sottogruppo di pazienti che avevano avuto infezioni prolungate raramente, se non mai, corrispondevano a quelle delle varianti circolanti all’interno della più ampia comunità globale.
“Molto ciò che rende un virus efficace è la sua capacità di sfuggire all’immunità”, ha affermato Lauring.
“Tuttavia, l’immunità è eterogenea: ciò che potrebbe portare un virus a sfuggire al sistema immunitario in un paziente immunocompromesso rispetto ai pazienti a livello di popolazione è diverso.”

Poiché l’immunità globale cambia a causa della vaccinazione e dell’infezione , la sorveglianza di questa particolare popolazione di pazienti per nuove varianti potrebbe non essere pratica, ha spiegato.
Lo studio fornisce informazioni molto necessarie su quali pazienti immunocompromessi corrono il rischio maggiore, afferma Lauring. Spera che lo studio porti anche a riorientare gli sforzi per sviluppare terapie migliori per questi pazienti.