Una recente e meticolosa ricerca condotta presso l’Università di Tel Aviv ha portato alla luce una potenziale correlazione tra la somministrazione di farmaci antiacidi a neonati durante i primi sei mesi di vita e un aumentato rischio di sviluppare la celiachia autoimmune in specifiche condizioni di studio. Questa associazione è stata osservata in un’ampia analisi di coorte che ha coinvolto i dati di oltre 79.000 bambini.

Terapia anti-acida infantile e rischio di celiachia autoimmune
È importante notare che tale correlazione non è emersa in una successiva e separata analisi caso-controllo condotta con test negativi per la celiachia nel gruppo di controllo. Questa discrepanza nei risultati solleva interrogativi significativi sull’esistenza di una relazione causale osservabile e sottolinea la necessità di ulteriori indagini per chiarire la potenziale connessione tra l’uso precoce di farmaci antiacidi e l’insorgenza della celiachia autoimmune.
Negli ultimi anni, si è assistito a un incremento significativo a livello globale nella prescrizione e nell’utilizzo di terapie farmacologiche acido-soppressive in età infantile. Queste terapie comprendono principalmente gli inibitori della pompa protonica (IPP), come l’omeprazolo (commercializzato con il nome di Prilosec), e gli antagonisti del recettore dell’istamina-2 (anti-H2), come la ranitidina (nota in passato come Zantac).
Questo aumento nell’uso pediatrico di tali farmaci ha destato crescente preoccupazione nella comunità scientifica, in quanto studi osservazionali precedenti hanno suggerito una potenziale associazione tra l’esposizione precoce a questi farmaci e l’insorgenza di effetti avversi a lungo termine, tra cui un aumentato rischio di fratture ossee e lo sviluppo della celiachia.

La celiachia è definita come un’enteropatia immunomediata, una condizione in cui una risposta immunitaria anomala e inappropriata al glutine, una proteina presente nel grano, nell’orzo e nella segale, provoca danni significativi alla mucosa che riveste l’intestino tenue. Questo danno alla mucosa intestinale comporta un aumento della sua permeabilità e l’attivazione di una risposta immunitaria cronica e persistente. È preoccupante osservare che la prevalenza e l’incidenza della celiachia sono aumentate nella maggior parte dei Paesi occidentali nel corso degli ultimi decenni. Questo incremento è stato riscontrato sia per la celiachia autoimmune sieropositiva, diagnosticata attraverso la rilevazione di specifici autoanticorpi nel siero, sia per la celiachia confermata mediante biopsia intestinale, che evidenzia il danno istologico caratteristico.
Meccanismi patogenetici noti suggeriscono che la terapia acido-soppressiva potrebbe potenzialmente contribuire allo sviluppo della celiachia attraverso diversi percorsi. In primo luogo, la soppressione dell’acidità gastrica potrebbe interferire con la normale digestione delle proteine, portando alla formazione di peptidi di glutine più grandi e potenzialmente più immunogenici che raggiungono l’intestino tenue.In secondo luogo, l’alterazione dell’ambiente acido dello stomaco potrebbe influenzare negativamente la composizione e la funzionalità del microbiota intestinale, l’insieme di microrganismi che risiedono nel nostro intestino, il cui equilibrio è sempre più riconosciuto come un fattore cruciale nella modulazione della risposta immunitaria e nello sviluppo di malattie autoimmuni.
Al fine di investigare in modo approfondito la potenziale associazione tra l’uso precoce di terapie farmacologiche acido-soppressive in età infantile e il successivo rischio di sviluppare l’autoimmunità alla celiachia, i ricercatori dell’Università di Tel Aviv hanno adottato un approccio metodologico basato sull’esecuzione di analisi retrospettive.

Queste analisi sono state condotte utilizzando ampi set di dati a livello di popolazione, consentendo di esaminare un numero elevato di individui e di valutare le potenziali correlazioni statistiche tra l’esposizione ai farmaci antiacidi nei primi mesi di vita e la successiva diagnosi di autoimmunità celiaca. La natura retrospettiva dello studio implica che i ricercatori hanno analizzato dati sanitari già esistenti, ricostruendo la storia farmacologica dei neonati e valutando la successiva comparsa di indicatori di autoimmunità celiaca.
Studio di coorte appaiato e analisi caso-controllo con gruppo di controllo test-negativo
Per esaminare in modo rigoroso e da diverse prospettive epidemiologiche la potenziale relazione tra l’esposizione precoce a farmaci antiacidi e il successivo sviluppo di autoimmunità celiaca, i ricercatori dell’Università di Tel Aviv hanno implementato un disegno di studio complesso e articolato.
Questo approccio metodologico si è basato sull’esecuzione di due analisi osservazionali retrospettive complementari: in primo luogo, uno studio di coorte appaiato, progettato per seguire nel tempo un gruppo di neonati esposti e non esposti alla terapia antiacida; in secondo luogo, un’analisi caso-controllo con un gruppo di controllo specificamente selezionato per aver ricevuto un test negativo per la celiachia, al fine di minimizzare il rischio di includere individui con malattia non diagnosticata.
Entrambe le analisi hanno sfruttato la ricchezza di dati a livello di popolazione provenienti da Maccabi Healthcare Services, una delle principali organizzazioni sanitarie israeliane che copre oltre un quarto dell’intera popolazione del paese, fornendo una base di dati ampia e rappresentativa per condurre indagini epidemiologiche di elevata potenza statistica.

I dati analizzati sono stati meticolosamente estratti dalle cartelle cliniche elettroniche di bambini nati in un ampio arco temporale compreso tra il 2005 e il 2020, che sono rimasti iscritti al sistema sanitario di Maccabi Healthcare Services per i primi cruciali sei mesi di vita. Questa finestra temporale iniziale è stata considerata fondamentale in quanto rappresenta il periodo di potenziale esposizione ai farmaci antiacidi oggetto dell’indagine. Un totale di 79.820 bambini hanno soddisfatto i criteri di inclusione e sono stati pertanto inclusi nell’analisi dello studio di coorte appaiata.
All’interno di questa coorte, un sottogruppo di 19.955 bambini aveva ricevuto una terapia acido-soppressiva, basata sulla somministrazione di omeprazolo (il principio attivo del farmaco Prilosec) o ranitidina (il principio attivo del farmaco Zantac), entro i primi sei mesi di vita. Per consentire un confronto rigoroso e minimizzare potenziali fattori di confondimento, ogni bambino esposto alla terapia antiacida è stato accuratamente abbinato a un massimo di tre bambini non esposti, selezionati in base a caratteristiche demografiche e di salute simili, al fine di creare gruppi di confronto comparabili.
Il periodo di follow-up per i bambini inclusi nello studio di coorte è stato esteso significativamente nel tempo, protrandosi fino al raggiungimento dell’età di 10 anni, all’eventuale uscita del bambino dal sistema sanitario di Maccabi Healthcare Services per qualsiasi motivo, o alla formulazione di una diagnosi di celiachia autoimmune, consentendo di osservare l’insorgenza della condizione nel corso dell’infanzia.

L’analisi dei dati longitudinali raccolti nello studio di coorte appaiata ha rivelato un’associazione statisticamente significativa tra l’esposizione precoce alla terapia acido-soppressiva e un aumentato rischio di sviluppare autoimmunità alla celiachia nel corso dell’infanzia. Nello specifico, è emerso che l’1,6% dei bambini che avevano ricevuto una terapia antiacida durante i primi sei mesi di vita ha successivamente sviluppato autoimmunità alla celiachia, definita dalla comparsa di specifici autoanticorpi nel siero.
Questo dato è stato confrontato con l’incidenza dell’1,0% riscontrata nel gruppo di bambini che non erano stati esposti a tali farmaci durante la prima infanzia. Per quantificare la forza di questa associazione, i ricercatori hanno calcolato un hazard ratio aggiustato di 1,52 per lo sviluppo della condizione di autoimmunità celiaca nei bambini che avevano utilizzato la terapia acido-soppressiva. L’hazard ratio è una misura statistica utilizzata negli studi di sopravvivenza per confrontare il tasso di occorrenza di un evento (in questo caso, la diagnosi di autoimmunità celiaca) tra due gruppi nel tempo, e un valore superiore a 1 indica un aumento del rischio nel gruppo esposto.
Ulteriormente, l’analisi ha rivelato una correlazione dose-risposta, suggerendo che un’associazione ancora più forte tra l’uso di terapia acido-soppressiva e l’autoimmunità celiaca è stata osservata nei sottogruppi di bambini che avevano utilizzato questi farmaci per un periodo di tempo più prolungato, superiore a un mese. In questo sottogruppo con esposizione prolungata, l’hazard ratio aggiustato per lo sviluppo di autoimmunità celiaca è risultato pari a 1,65, indicando un aumento del rischio ancora maggiore rispetto all’uso di durata inferiore. Questi risultati dello studio di coorte suggeriscono quindi una potenziale implicazione dell’uso precoce e prolungato di farmaci antiacidi nello sviluppo dell’autoimmunità celiaca nei bambini.
Risultati contrastanti sull’associazione tra terapia anti-acida infantile e autoimmunità celiaca
Parallelamente all’analisi di coorte appaiata, i ricercatori hanno condotto un’ulteriore indagine epidemiologica utilizzando un disegno caso-controllo con un gruppo di controllo specificamente selezionato per aver ricevuto un risultato negativo al test per l’autoimmunità celiaca. Questa strategia metodologica mirava a mitigare il potenziale bias di rilevamento, ovvero la possibilità che l’esposizione alla terapia anti-acida potesse influenzare la probabilità di essere sottoposti al test per la celiachia.

Il gruppo caso era costituito da bambini diagnosticati con autoimmunità celiaca, mentre il gruppo di controllo comprendeva 24.684 bambini che erano stati sottoposti al test per gli autoanticorpi della celiachia e avevano ottenuto un risultato negativo. L’analisi si è concentrata sulla comparazione dei tassi di esposizione alla terapia acido-soppressiva durante i primi sei mesi di vita tra i bambini del gruppo caso e quelli del gruppo controllo.
L’analisi dei tassi di esposizione alla terapia acido-soppressiva ha rivelato che tra i bambini risultati positivi al test per l’autoimmunità celiaca (il gruppo caso), il 5,0% aveva ricevuto una terapia anti-acida durante i primi sei mesi di vita. Nel gruppo di controllo, costituito dai bambini risultati negativi al test per l’autoimmunità celiaca, il tasso di esposizione alla terapia anti-acida era del 4,6%. Il calcolo dell’odds ratio aggiustato per questo confronto tra i due gruppi ha prodotto un valore di 1,07.
È cruciale sottolineare che questo valore dell’odds ratio, che quantifica la forza dell’associazione tra l’esposizione e l’esito, non ha raggiunto la significatività statistica. Un odds ratio di 1,07 indica una differenza molto piccola e non statisticamente robusta nella probabilità di esposizione alla terapia anti-acida tra i bambini con e senza autoimmunità celiaca nel gruppo test-negativo. Questo risultato contrasta in modo netto con l’associazione significativa riscontrata nell’analisi dello studio di coorte, in cui l’uso della terapia acido-soppressiva era significativamente associato a un aumentato rischio di sviluppare autoimmunità celiaca.
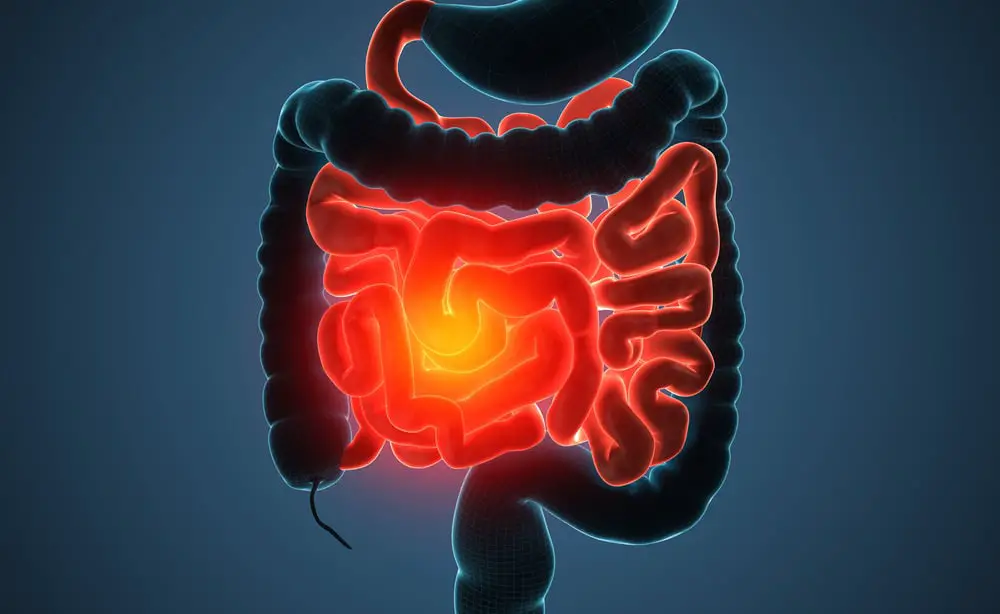
La discrepanza nei risultati ottenuti dai due disegni osservazionali retrospettivi utilizzati in questo studio solleva importanti considerazioni sull’interpretazione dei dati osservazionali in ambito epidemiologico. Sebbene lo studio di coorte abbia evidenziato un’associazione significativa tra la terapia acido-soppressiva infantile e l’autoimmunità celiaca, l’assenza di un’associazione significativa nell’analisi caso-controllo con test negativo suggerisce che la relazione osservata nella coorte potrebbe essere potenzialmente influenzata da fattori di confondimento non completamente controllati.
Gli autori stessi riconoscono questa limitazione, osservando che il disegno di coorte potrebbe aver indirettamente riflettuto un “confondimento residuo” associato alla probabilità di essere sottoposti al test per la celiachia. In altre parole, potrebbe esistere un altro fattore, non misurato o non adeguatamente controllato nell’analisi, che sia correlato sia all’uso della terapia anti-acida che alla probabilità di essere testati per la celiachia. Ad esempio, i bambini con determinate condizioni gastrointestinali potrebbero essere più propensi a ricevere sia la terapia anti-acida che il test per la celiachia, creando un’associazione spuria.

La mancanza di significatività nell’analisi caso-controllo, progettata per mitigare questo bias, suggerisce che tale confondimento potrebbe effettivamente aver giocato un ruolo nei risultati della coorte. I risultati complessivi di questo studio sottolineano la complessità intrinseca nel trarre conclusioni definitive basandosi esclusivamente su dati osservazionali, evidenziando la necessità di ulteriori ricerche, possibilmente con disegni di studio prospettici e randomizzati, per chiarire in modo definitivo la potenziale relazione causale tra l’uso precoce di farmaci antiacidi e il rischio di sviluppare la celiachia autoimmune.
Lo studio è stato pubblicato su JAMA Network Open.