L’insorgenza della resistenza ai farmaci antitumorali rappresenta uno dei problemi più critici e urgenti nell’ambito dell’oncologia. È fondamentale sviluppare nuove strategie per mitigarla. Nonostante l’importanza di tale obiettivo, i meccanismi molecolari che guidano questa resistenza del cancro sono ancora poco chiari, il che ostacola la progettazione di nuove ed efficaci terapie preventive.

Cancro: un nuovo, paradossale meccanismo di sopravvivenza cellulare
In questo contesto, ricercatori dell’Università della California di San Diego hanno fatto una scoperta sorprendente che sovverte la comprensione della morte cellulare neoplastica. Hanno identificato un meccanismo paradossale attraverso il quale le cellule tumorali riescono a sopravvivere e a ricrescere dopo una terapia mirata: dirottano un enzima che in condizioni normali viene attivato unicamente per avviare la morte cellulare.
L’autore principale dello studio, Matthew J. Hangauer, Ph.D., ha affermato che questa scoperta “capovolge completamente la nostra comprensione della morte delle cellule cancerose”.
Le cellule tumorali che non vengono distrutte dal trattamento farmacologico iniziale non interrompono la cascata di segnali legati alla morte. Al contrario, subiscono una segnalazione di morte cellulare subletale che, anziché ucciderle, favorisce attivamente la ricrescita del tumore. Il Dott. Hangauer ha concluso che bloccando specificamente questa segnalazione di morte all’interno delle cellule tumorali sopravvissute, sarebbe possibile impedire la recidiva dei tumori durante la terapia.
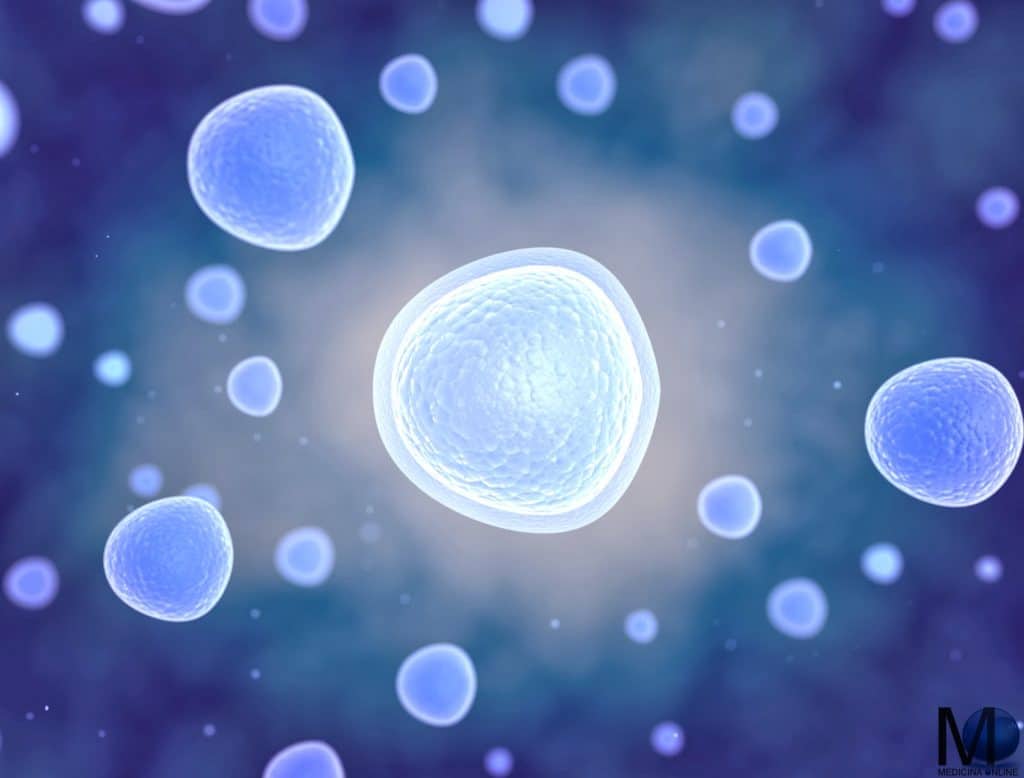
Tradizionalmente, il cancro sviluppa resistenza attraverso mutazioni genetiche che si accumulano nell’arco di mesi o anni, un processo difficile da contrastare con gli attuali approcci farmacologici. Questo meccanismo di resistenza è responsabile di circa un decesso su sei a livello globale.
Il meccanismo appena scoperto è di particolare interesse perché non è legato a mutazioni genetiche e riguarda le fasi iniziali della resistenza. Ciò lo rende un bersaglio molecolare nuovo e promettente per lo sviluppo di future strategie terapeutiche che possano prevenire la resistenza acquisita.
Un paradigma di resistenza non genetica
Tradizionalmente, la maggior parte della ricerca sulla resistenza ai farmaci antitumorali si è concentrata sull’identificazione e l’analisi delle mutazioni genetiche. Tuttavia, il recente studio mette in luce l’esistenza di meccanismi di ricrescita tumorale di natura non genetica che possono manifestarsi nelle fasi molto precoci della terapia.
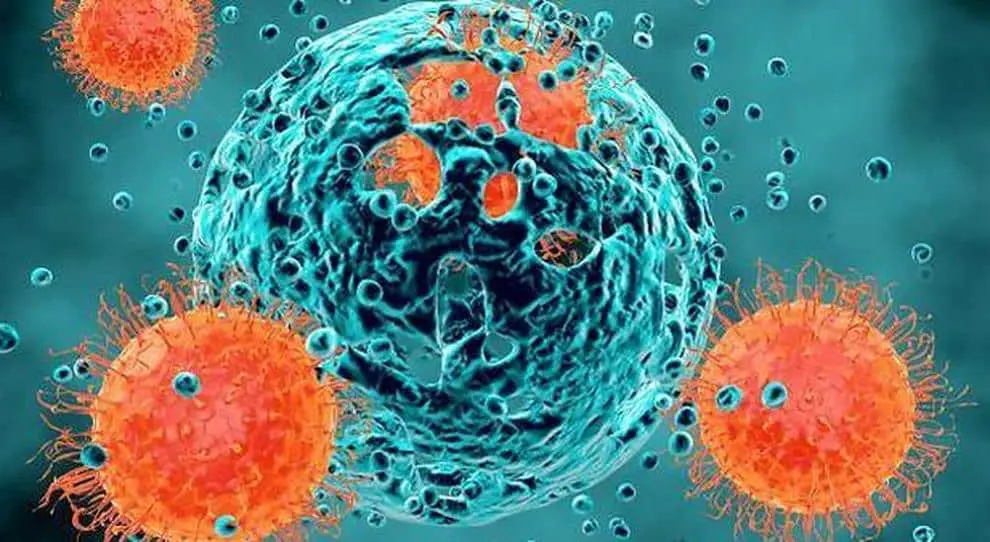
Il primo autore, August F. Williams, Ph.D., ha evidenziato che la dimostrazione di meccanismi non genetici apre la strada a nuove possibilità di cura. Poiché questi meccanismi non dipendono da mutazioni, possono potenzialmente essere affrontati con farmaci, contribuendo così a mantenere i pazienti in remissione più a lungo e a ridurre significativamente il rischio di recidiva.
Nello studio condotto su modelli di melanoma, cancro al polmone e cancro al seno, è stato identificato un sottoinsieme cruciale di cellule “persistenti”, ovvero quelle che riescono a sopravvivere al trattamento farmacologico iniziale. Queste cellule hanno mostrato un’attivazione cronica, ma a basso livello, di una proteina che normalmente è fondamentale per smantellare il DNA durante la morte cellulare programmata (apoptosi). Questa proteina è chiamata fattore di frammentazione del DNA B (DFFB).
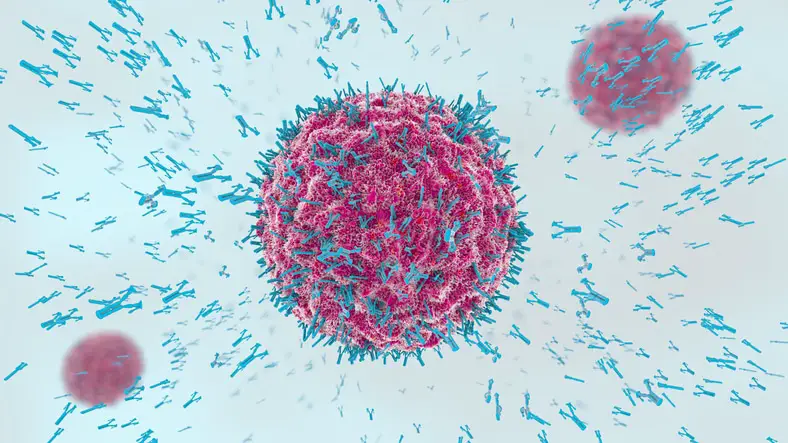
L’attivazione della proteina DFFB in queste cellule persistenti si verifica a un livello troppo basso per innescare la loro morte effettiva. Tuttavia, questa attivazione subletale è sufficientemente elevata da interferire con la capacità delle cellule di rispondere ai segnali interni che tipicamente sopprimono la loro crescita e proliferazione. In sostanza, il segnale di morte viene dirottato per promuovere la sopravvivenza e la ricrescita.
Il fattore di frammentazione del DNA B (DFFB) come bersaglio terapeutico
La recente ricerca ha identificato il Fattore di Frammentazione del DNA B (DFFB) come un elemento cruciale e vulnerabile nelle cellule tumorali che sviluppano resistenza. Questa proteina, sebbene sia generalmente associata al processo di morte cellulare programmata (apoptosi), è stata scoperta svolgere un ruolo paradossale e indispensabile per la sopravvivenza delle cellule persistenti sotto trattamento farmacologico.
La rimozione sperimentale della proteina DFFB ha dimostrato un effetto diretto e significativo sulla biologia delle cellule tumorali persistenti. L’eliminazione di questa proteina non solo ha mantenuto le cellule in uno stato di dormienza, ma ha anche impedito in modo efficace la loro ricrescita e proliferazione in presenza di terapia farmacologica. Questo risultato suggerisce che il DFFB agisce come un interruttore molecolare che converte un segnale di danno subletale in un segnale di sopravvivenza e riattivazione cellulare.
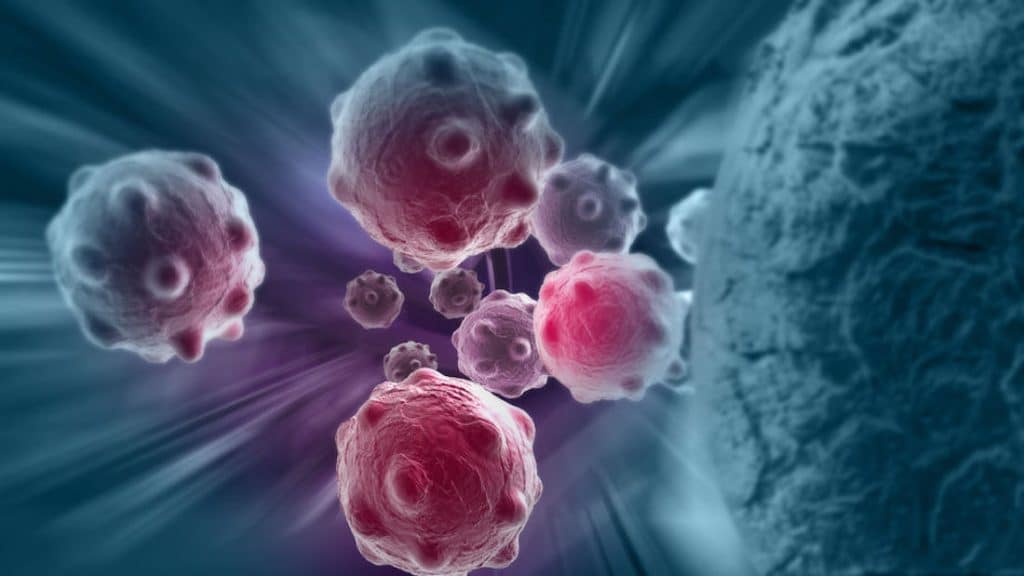
Il DFFB possiede una caratteristica molecolare che lo rende un bersaglio particolarmente promettente per lo sviluppo di nuovi farmaci e trattamenti combinati. È stato accertato che il DFFB non è essenziale per la sopravvivenza o il funzionamento delle cellule normali dell’organismo. Questa non-essenzialità nelle cellule sane è un vantaggio cruciale, poiché minimizza il rischio di effetti collaterali sistemici gravi, un problema comune con molti farmaci che mirano a bersagli presenti sia nelle cellule tumorali che in quelle normali.
Al contrario, la proteina DFFB si è dimostrata necessaria per la ricrescita e la riattivazione delle sole cellule tumorali persistenti. In sostanza, il cancro ha sviluppato una dipendenza selettiva da questa proteina per eludere la terapia. Questa differenza di dipendenza tra cellule sane e cellule tumorali persistenti rende il DFFB un bersaglio ideale. L’identificazione del DFFB crea un’opportunità strategica per estendere l’efficacia delle terapie mirate esistenti.
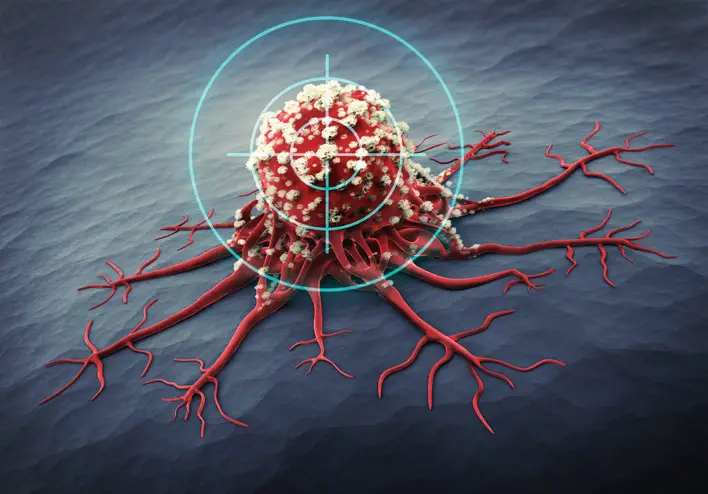
I ricercatori propongono l’utilizzo di trattamenti combinati che affianchino l’attuale terapia antitumorale mirata con un inibitore specifico del DFFB. L’obiettivo non sarebbe primariamente quello di indurre la morte immediata delle cellule tumorali residue, ma piuttosto di neutralizzare il meccanismo di ricrescita non genetica, forzando le cellule persistenti in uno stato di dormienza prolungata.
Tale approccio ha il potenziale di estendere significativamente le risposte terapeutiche e di prevenire la recidiva del tumore, superando le limitazioni imposte dalla resistenza acquisita che, troppo spesso, annulla i benefici iniziali del trattamento.
Lo studio è stato pubblicato su Nature Cell Biology.